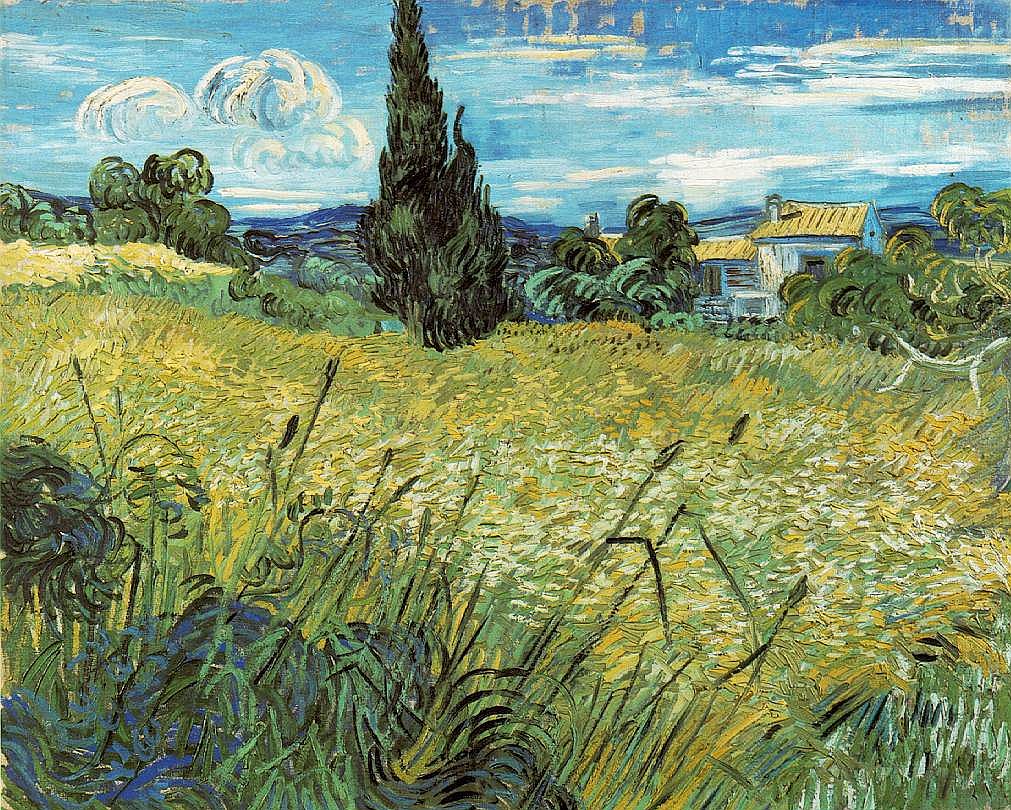Adottato il Regolamento UE/1143/2024, che porta la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)
La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai attuata con l’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia.
I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa
.
Due i criteri principali.
Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?
.
Uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.
Introdotte inoltre significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.
Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela: attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.
Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.
Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.
Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.
A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace. Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.
Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?
.
Ad ogni modo, non si è giunti ad un’unica definizione di indicazione geografica.
Continuano a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:
-
-
- prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
- vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
- bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )
-
Ciò in quanto la loro disciplina è diversa in sede WTO (e cioiè negli accordi TRIPS).
Analogamente vale per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.
Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).
Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa viene comunque meno per effetto dell’armonizzazione introdotta dal Regolamento 1143/202.
Poca attenzione alla sostenibilità.
.
Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.
Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
Le decisioni che hanno portato alla riforma.
.
Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).
.
L’approvazione da parte del Consiglio Europeo è intervenuta il 26/3/2024.
Si è giunti così all’adeozione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.