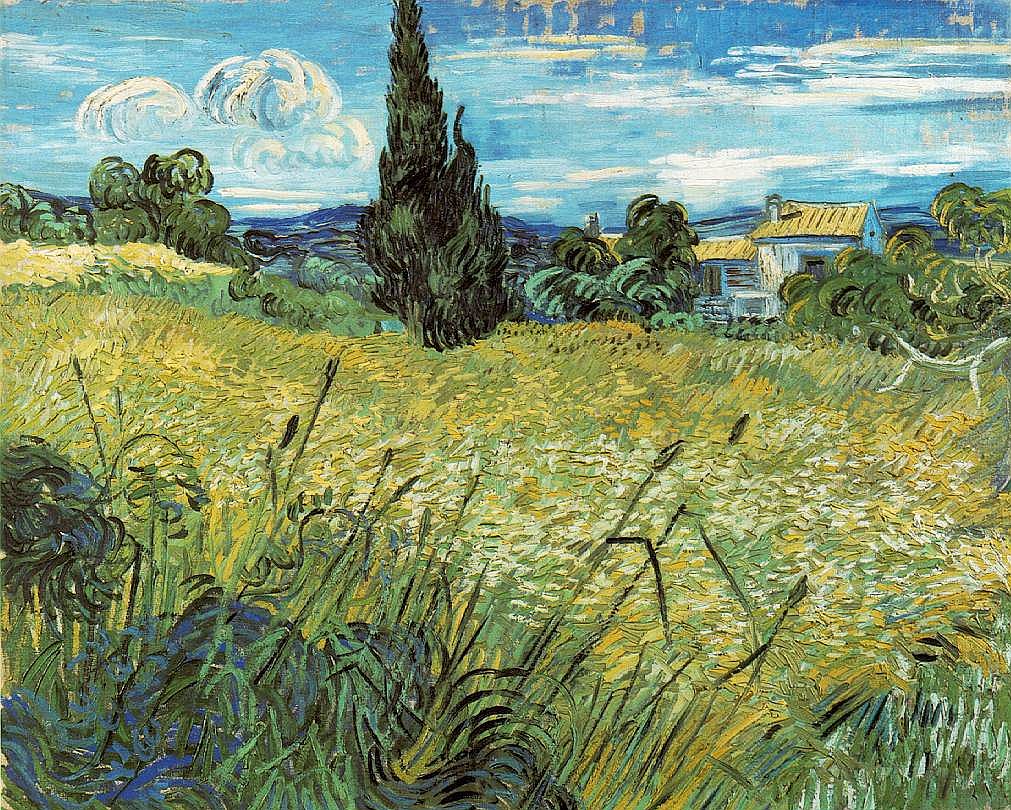La tipicità vini DOP IGP, rappresentante l’espressione dei loro specifici territori di riferimento, viene individuata nei rispettivi disciplinari di produzione.
La tipicita vini DOP IGP costituisce dunque la “firma” di ciascun territorio sui propri vini. Viene espressa nei disciplinari di produzione. Ma è cosa immediata per tutti percepirla dalla loro lettura?
I disciplinari di produzione, chiave di volta per la tutela legale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
La tipicità dei singoli vini DOP e IGP trova espressione (o, meglio, sintesi) nei rispettivi disciplinari di produzione, i quali rappresentano l’elemento cardine per la tutela delle denominazioni geografiche (DOP, in Italia suddivise in DOC e DOCG) e le indicazioni tipiche (IGP, in Italia definite anche IGT), sia a livello dell’Unione Europea (per effetto degli art.92 e ss. del regolamento UE/1308/2013), sia al di fuori dei suoi confini, grazie ai numerosi accordi intenazionali conclusi al riguardo dall’UE con gli Stati terzi.
Disciplinari vini DOP - IGP italiani
All’interno di ciascun disciplinare, poi, i punti più indicativi circa la tipicità del vino (Tipicita vini DOP IGP) sono i “requisiti organolettici” (dato peraltro obbligatorio ai sensi della legislazione unionale: art.93, comma 2, del regolamento UE/1308/2013).
Inoltre, i disciplinari devono anche indicare le caratteristiche climatiche, geologiche e morfologiche dei loro territori , dovendo chiarire “il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico“, ma intuirne l’influenza sulla tipicità del vino diviene discorso meno intuitivo.
La tutela legale di DOP e IDP prescinde tuttavia dalla distinguibilità dei prodotti commercializzati con il nome oggetto di protezione.
.
A rigore, però, secondo il diritto europeo la tutela in favore delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche viene concessa anche se il prodotto (vino o alimento), che vuole fregiasi del nome protetto (e cioè il nome geografico del proprio territorio, costituente la DOP o la IGP) non presenta i caratteri della distinguibilità (Corte di Giustizia, sentenza «Torrone di Alicante» del 10 novembre 1992, in causa C-3/91 )
In effetti, per il diritto europeo (Corte di Giustizia, sentenza 14 settembre 2017, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, in causa C‑56/2016, punto 82), la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è piuttosto volta a difendere la loro reputazione e
costituisce uno strumento della politica agricola comune mirante essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti
Le fonti della tipicità: le caratteristiche del territorio e l’influenza umana, come individuati dal disciplinare di produzione.
.
Ciò posto, se poi si esaminano i “requisiti organolettici” imposti da ciascun disciplinare, si realizza che – essendo essi volutamente espressi in modo estrermamente sintetico – quanto ivi descritto rappresenta in realtà una sorta di “macro-modello”.
Insomma, è un qualcosa piuttosto lontano rispetto alla descrizione che solitamente un sommeiler/assaggiatore rende in fase di degustazione, ove peraltro le schede di valutazione tendono a concentrarsi sulle sensazioni organolettiche stesse (di cui si ricerca la loro qualità ed equilibrio), lasciando però poco o nessuno spazio alla valutazione della tipicità (si veda la scheda ONAV, ad esempio).
Il disciplinare, infatti, definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe in effetti una cosa “terribile”) di standardizzarle.
All’interno del “macro-modello”, quindi, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione (sempre più spesso diviso in sotto-zone o aree geografiche, si pensi al caso del Barolo) nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.
Ciò nonostante, nel momento in cui il produttore di un vino, atto a divenire DOP (DOC o DOCG), vuole immettere sul mercato il proprio prodotto, i relativi campioni sono soggetti all’esame (svolto “alla cieca”) dalle competenti commissioni di degustazione, che ne valutano l’ideoneità e, dunque, anche la tipicità (tipicita vini DOP IGP).
Solo se tale esame viene superato, il vino potrà portare in etichetta il nome del proprio territorio (accompagnato dalla pertinente menzione: DOC o DOCG), il quale viene così a rappresentare una garanzia di qualità per il consumatore (e cioè il vino è conforme ai requisiti imposti dal disciplinare di produzione).
Il rispetto del disciplinare assicura sempre la tipicità?
.
La tipicità, rappresentante la “comune nota di fondo” che i differenti territori conferiscono ai loro rispettivi vini (tipicita vini DOP IGP), è quindi frutto delle molteplici interazioni tra l’insieme dei fattori presi in considerazione dai relativi disciplinari.
“Nota di fondo” che troverà poi una propria “declinazione” – tutta da scoprire – per effetto delle varie annate, delle differenze morfologiche e geologiche dei singoli appezzamenti, delle scelte dell’enologo, etc …
Tuttavia, il rispetto del disciplinare deve necessariamente portare alla realizzazione di un vino che esprime la tipicità delineata nel disciplinare stesso.
Questo passaggio non può mancare, altrimenti il vino – per quanto buono o sublime – non è espressione del territorio di riferimento, ma solo del suo produttore (il che è nobile, ma esula dalla filosofia delle denominazioni di origine).
La situazione appare però molto complessa, giacché in alcuni casi ad uno specificio terriorio corrisponde una sola DOP; in altri casi, lo stesso territorio è frazionato in varie distinte DOP; in altri ancora, sullo stesso territorio si sovrappongono – almeno parzialmente – diverse DOP e/o IGP. Insomma, siamo nel mondo della complessità, ma proprio ciò rappresenta uno degli elementi di fascino di quello dei vini.
Ciò posto, ragionare in termini di tipicità diviene tuttavia più difficile, con riferimento alle cosiddette DOC “regionali”, e cioè quelle che coincidono con l’intero terriorio di una Regione (quali Piemonte, Sicilia, ….).
In effetti, la loro ampiezza geografica porta necessariamente a comprendere zone dalle caratteristiche geologiche, morfologiche e climatiche molto eterogenee fra loro.
Inoltre, i relativi disciplinari molto spesso si limitano a richiamare i requisiti chimico-fisici (o, comunque, non si allontano molto da loro) previsti dalla normativa unionale (Allegato VII al regolamento 1308/2013) per le varie categorie di prodotti vitivinicoli.
Di conseguenza, nel caso delle DOC “regionali”, la tutela trova forse maggiore ragione nella volontà di proteggere la reputazione commerciale (conformemente alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia nelle citate sentenze) di tali nomi geografici. Inoltre, il consumatore è garantito da controlli più incisivi, rispetto a quelli effettuati sui vini senza denominazione.
Ne discende che il ragionare in termini di tipicità si addice forse maggiormente per le denominazioni con un’estensione territoriale più limitata, per quanto anche in questo caso il rispettivo territorio possa presentare caratteristiche eterogenee al suo interno.
Difatti, se l’estensione territoriale di una denominazione è contenuta, risulta più facile coglierne gli aspetti comuni di fondo, anche grazie ai relativi disciplinari (i quali, peraltro, limitano effettivamente le varietà ampelogratiche utilizzabili, le rese massime per ettaro e/o di trasformazione dell’uva in mosto ovvero prevedono requisiti chimici ed analitici più rigorosi per il prodotto finale).
.
La tipicità non emerge tuttavia in modo sempre immediato dai dati tecnici contenuti nel disciplinare, ma è in un certo senso lì “criptata” loro tramite, almeno agli occhi di chi non è un esperto del settore.
Individuare la tipicità del vino di un determinato territorio, illustrandola in modo discorsivo, rappresenta allora semplicemente un altro modo di leggere il relativo disciplinare, consentendo di capire in modo colloquiale, ma preciso, a quale risultato (nella forma di “macro modello”) esso conduce.
Non esistendo però una versione “ufficiale” sulla descrizione della tipicità (gli unici dati vincolanti sono infatti quelli indicati nel disciplinare stesso), la “decodificazione” apre un certo spazio soggettivo a disposizione dell’interprete.
Ecco la questione delicata: la “vulgata” (e cioè la descrizione della tipicità in termini colloquiali) è sempre fedele? Susssite il rischio che la definizione stessa della tipicità possa dipendere dall’eloquenza e dall’abilità retorica dell’interprete che la comunica?
Sul piano giuridico, la situazione si risolve comunque con il lavoro professionale svolto dalle citate commissioni di valutazione: se al loro assaggio un certo vino DOP è ritenuto idoneo, esso soddisfa i requisiti organolettici previsti dal disciplinare e, quindi, integra la relativa tipicità.
Qalora “promosso” in sede di siffatto controllo (che avviene nel finale della fase produttiva), il vino può essere allora commercializzato spendendo legittimamente in etichetta il nome del relativo territorio, a cui lo specifico disciplinare si riferisce, unitamente alla sigla DOP (DOC-DOCG a seconda dei casi, in Italia).
Tale verifica avviene però solo a campione per i vini IGP/IGT (indicazione geografica protetta), la cui protezione spesso è riconducibile all’esigenza di salvaguardare la notorietà del relativo nome geografico (art.93, comma 1, lettera b, del Regolamento UE/1308/2013), il che di fatto avvicina alquanto tale situazione a quella delle DOP regionali (ferme le differenze esistenti sul piano giuridico, quanto a requisiti ed intensità dei controlli).
Tutto ciò è ancora attuale?
.
Quanto esposto riflette l’approccio tradizionale al tema della denominazioni di origine, di cui la tipicità rappresenta un aspetto fondamentale.
Recenti riflessioni mettono però in dubbio le fondamenta di tutto il discorso, come si evice dalla posizone assunta da Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC.
A suo parere (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):
“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. …
… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.
… Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...
… Oggi una Doc è mito o realtà ? Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione. La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.
Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.
Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.
In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …
Qualche considerazione “a caldo”
.
Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.
Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quelle “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetti tali criteri) con quello prodotto da una cantina che rispetta rigorosi parametri ESG (che non sono quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, vista la debolezza dei criteri relativi agli aspetti sociali e di governance)?
Ancora: è allora più corretto l’approccio seguito negli Stati Uniti (modificato solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quanto sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?
Infine: la protezione alle denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?
Quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?