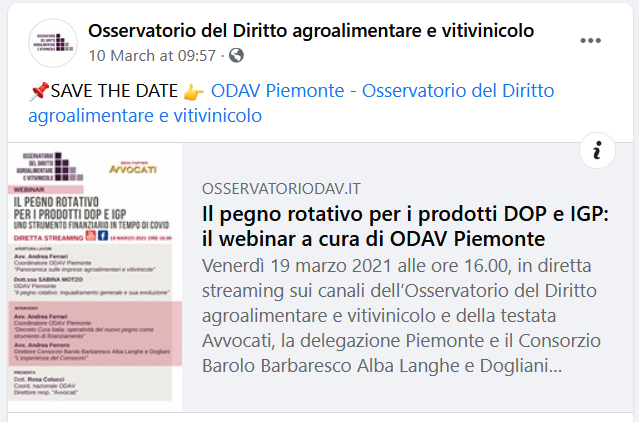Usucapione del fondo agricolo: per maturarla non basta che il possessore si limiti alla mera coltivazione (usucapione fondo agricolo coltivazione)
Con l’ordinanza n.1796 del 20 gennaio 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’usucapione del fondo rustico (usucapione fondo agricolo coltivazione).
Più precisamente, con la predetta pronuncia la Suprema Corte ha rimarcato il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, la mera coltivazione del fondo.
L’istituto dell’usucapione fonda le sue origini nel diritto romano e costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento (ad esempio della servitù di passaggio) su beni mobili o immobili. L’acquisizione del diritto si perfeziona con il decorso del tempo.
In tema di proprietà immobiliare, l’art.1158 c.c. sancisce che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
Il successivo art.1159 c.c. riduce il tempo del possesso c.d. “ad usucapionem” a dieci anni in favore di colui che abbia acquistato in buona fede, da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà che sia stato debitamente trascritto.
In entrambi i casi si parla di possesso, ma non ogni tipo di possesso può definirsi come utile a perfezionare l’usucapione. Invero, ai fini dell’usucapione, il possesso deve avere determinate caratteristiche: deve essere stato assunto in modo pacifico (e cioè non attraverso uno spoglio violento o clandestino) e deve mantenersi nella sfera del possessore in modo ininterrotto e non equivoco. Si parla di possesso “uti dominus”, che sta sostanzialmente ad indicare l’elemento soggettivo del possesso, ossia che il soggetto che lo esercita si comporta come se fosse il proprietario.
Precisati tali elementi identificativi della fattispecie, ritorniamo ad esaminare la suddetta Ordinanza, la quale ha affrontato il tema degli effetti della coltivazione del fondo nell’ambito del riconoscimento del diritto di usucapione. Secondo detta pronuncia, la coltivazione
«…non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301). La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi , i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso».
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. “ius excludendi alios”), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il possessore abbia dimostrato non soltanto di avere utilizzato il bene immobile su cui egli reclama l’usucapione, ma di averne anche precluso ai terzi la fruizione.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che – per loro stessa natura – sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo “ius excludendi alios” possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello “ius excludendi alios” Ciò non implica che venga impedito di dare in altro modo la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene.
Tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisce una univoca e chiara manifestazione della volontà del possessore di escludere i terzi da qualsiasi relazione con il fondo stesso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento.
Si può quindi concludere che, poiché l’attività di coltivazione è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale (un accordo, un contratto o anche sulla mera tolleranza del proprietario), non esprime un’attività di per sé idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, poiché solo l’escludere i terzi costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà.
Dovrà quindi il soggetto coltivatore (ad esempio chi originariamente era affittuario del terreno e, scaduto il contratto, ha continuato a coltivare il fondo senza più corrispondere il canone e senza che il proprietario intervenisse per ottenere la riconsegna del terreno) deve attuare ulteriori comportamenti che – in modo inequivoco – evidenzino il possesso “uti dominus”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6682/2017 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO CORNACCHIA;
– ricorrente –
contro
M.T., G.M., e GR.MO., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO MARELLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato nel giugno 2003 M.T., G.M. e Gr.Mo. evocavano in giudizio S.C. innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un fondo sito nel territorio del Comune di (OMISSIS). Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 455/2016, rigettava la domanda, ritenendo insufficiente, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, la mera coltivazione del fondo.
Interponevano appello avverso detta decisione le originarie attrici e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 384/2017, resa nella resistenza della S., riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di usucapione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.C., affidandosi ad un unico motivo, articolato in diversi profili.
Resistono con controricorso M.T., G.M. e Gr.Mo..
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Motivi della decisione
Con il l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 114, 1158, 1159, 1165 c.c., artt. 184, 346, 115, 116, 246 e 346 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura, in realtà, si articola in sei distinti profili.
In primo luogo, la S. contesta l’affermazione secondo cui il teste D., che aveva curato i suoi interessi in passato, aveva un potenziale interesse alla causa e fosse dunque inattendibile. In secondo luogo, la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della Corte distrettuale, che l’occupazione del terreno da parte degli odierni controricorrenti, e prima di essi del loro dante causa, era dovuta a mera tolleranza della S., come – tra l’altro – confermato proprio dalla testimonianza D.. In terzo luogo, la S. lamenta l’erronea valorizzazione, da parte del giudice di seconda istanza, della semplice coltivazione del fondo, che di per sè non costituirebbe elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem. In quarto luogo, la ricorrente si duole dell’erronea valutazione delle dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio. In quinto luogo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente configurato l’usucapione del terreno ai sensi dell’art. 1159 c.c., senza considerare che la coltivazione del fondo non rileva ai fini della prova del possesso utile ad usucapire. Infine, la S. contesta la ricostruzione operata dal Giudice di merito, poichè gli odierni controricorrenti potevano al massimo essere ritenuti meri detentori dell’immobile, ma non possessori.
Il terzo, quinto e sesto profilo dell’unica articolata doglianza in esame, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Va, sul punto, ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perchè essa “…non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv.649349; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006, Rv. 587753, secondo cui “L’accertamento, in concreto, degli estremi dell’interversione del possesso integra un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicchè nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione”).
Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha condotto alcuna valutazione ulteriore rispetto alla verifica del mero fatto che i controricorrenti avessero coltivato il terreno, ed ha erroneamente ritenuto questo elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem. Merita di essere precisato, in proposito, che il possesso utile ai fini della configurazione dell’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l’esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poichè la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l’appunto, precluso ai terzi la fruizione.
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che – per loro stessa natura – sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento; esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.
In conclusione, può essere affermato il seguente principio di diritto: “In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poichè tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”.
L’accoglimento, nei termini indicati, del terzo, quinto e sesto profilo dell’unico motivo di ricorso, implica l’assorbimento dei restanti profili. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio si conformerà al principio di diritto espresso in motivazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo, quinto e sesto profilo dell’unico motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022